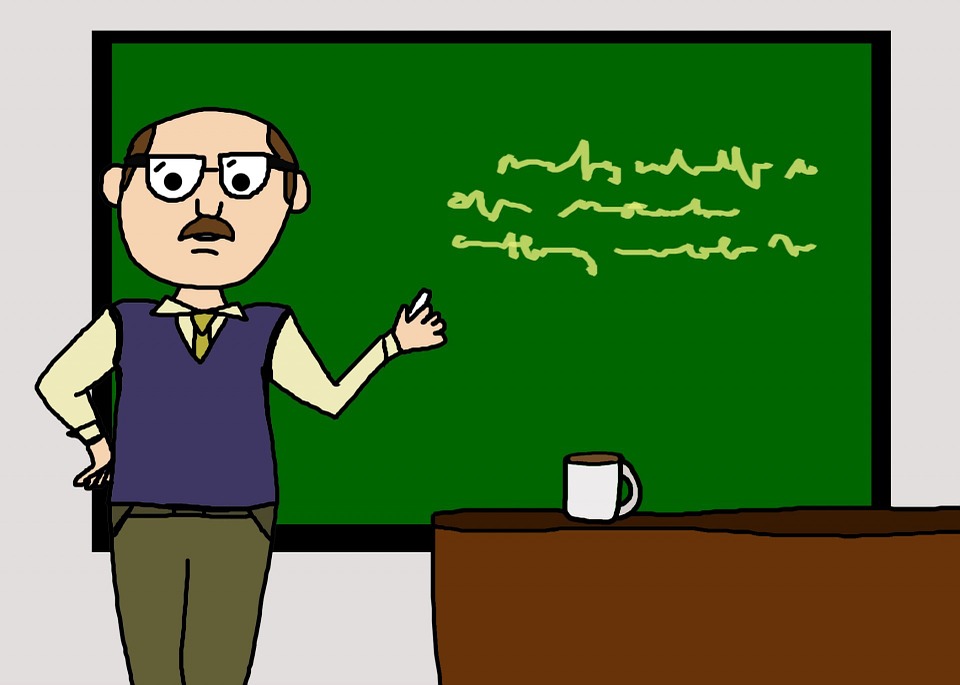Come smettere di autocommiserarsi e razionalizzare gli aspetti negativi del nostro mestiere
La giornata di un docente è fatta, se è fortunato, anche di qualche momento di conversazione con i colleghi. Ogni tanto, il docente medio si ricorda che esiste anche fuori dalla classe e chiede al collega i suoi programmi per il fine settimana; nove volte su dieci, però, pratica lo sport del lamento. Il docente medio non ce la fa, è parte del suo DNA! Gli fanno avere a casa il diploma in ‘Lamentazione di pubblica utilità’ non appena mette piede in un’aula.
Un po’ voglia di sfogarsi, un po’ parole a vuoto, un po’ reale difficoltà di fronte a situazioni nuove, che non immaginava si potessero verificare quando ha deciso di ‘fare il prof’. Vediamo insieme le lamentele più comuni e razionalizziamo: in fondo, anche lamentarsi che ci si lamenta troppo è una lamentela!
1 – ‘Una volta non era così! Randellate sulle dita, si davano…’
Dei vecchi sistemi scolastici si può ben rimpiangere qualcosa; a mente fredda, però, nessuno di noi sente veramente di poter approvare le punizioni corporali, per quanto alcuni atteggiamenti degli studenti potrebbero far passasere l’idea di applicarli.
2 – ‘In classe c’è rumore, sempre! Non c’è mai silenzio!’
Questa lamentela ha effettivamente ragione di levarsi, soprattutto se consideriamo che esiste una casistica consistente di docenti con problemi alle corde vocali: anno dopo anno, risulta dannoso lo sforzo causato dal bisogno di contrastare il ‘rumore di fondo’ per 18 ore a settimana. L’acustica delle scuole italiane, spesso fatiscenti, non è di aiuto. Risultato? Lamentarsi serve a poco: meglio iniziare a mangiar miele, bere tisane curative specifiche, andare da un foniatra e apprendere tecniche che ci aiutino a preservare uno dei nostri principali strumenti di lavoro. Prevenire è meglio che curare, soprattutto se, spesso, curare significa operarsi alle corde vocali.
D’altro canto, cerchiamo di sfatare un mito: la classe silenziosa (in stile ‘mite gregge di rilievo alpino’) non è necessariamente una classe attenta. Forse è una classe terrorizzata o annoiata, o sonnolenta. Allo stesso modo, una classe tendenzialmente rumorosa non è del tutto disattenta: è quantomeno viva. Se ricevete venticinque domande tutte insieme, forse è il caso di insegnare ai ragazzi come ci si comporta in una comunità, ma almeno siete sicuri che sono svegli. Certo, poi vi tocca rispondere a venticinque domande tutte uguali, ma stiamo cercando di razionalizzare le lamentele e quindi è bene concentrarci sui lati positivi, no?
3 – ‘Il dirigente/il preside/il coordinatore/il gran visir non capisce il mio stato d’animo/il mio problema/la situazione con quella classe’
Di ambienti lavorativi è pieno il mondo, e sono popolati da esseri umani. Gli esseri umani hanno i neuroni specchio e sono capaci di provare empatia, ma gli manca ancora il potere di leggere nel pensiero altrui. In altre parole: che le persone si capiscano perfettamente a vicenda è un’utopia, persino in un matrimonio di diamante! Resta sempre, nei nostri rapporti con l’altro, un confine invisibile, e forse è anche un bene.
A scuola siamo quotidianamente in gioco: abbiamo di fronte tra i 15 e i 30 bambini o ragazzi, sei ore al giorno, tutti i giorni. I ragazzi fanno rumore, creano problemi, pongono questioni complesse, discutono con i compagni, discutono con noi docenti, si fanno beccare a fumare nei bagni dagli ATA, si tagliano con le forbici, non fanno i compiti… la lista potrebbe continuare all’infinito.
È naturale che, vivendo una quotidianità fatta di attenzione continua all’altro, pretendiamo a un certo punto di essere capiti anche noi con la stessa attenzione. I nostri interlocutori, però, non sono esenti da problemi: il dirigente scolastico non raccatta le penne dei piccolini, però gira in macchina tra i suoi plessi, maledicendo di aver vinto il concorso tanto ambito e caracollando in mezzo alle risposte inconcludenti degli uffici MIUR. Siamo pazienti con i colleghi: in fondo, siamo tutti dalla stessa parte.
4 – ‘L’ho spiegato mille volte, ma i ragazzi non hanno ancora capito’
Può essere qualsiasi argomento: la tabellina del 7, il predicativo del soggetto, il gas perfetto, un esercizio sui limiti o sui passati dall’inglese. Lo avete spiegato per tre settimane e vi apprestate al ripasso finale, prima del fatidico compito in classe.
Si levano alti lamenti nella migliore tradizione epico-patetica, accompagnati da un generale ‘Prof, ma l’esercizio non mi viene!’. E voi da capo a spiegare, forsennati, per poi uscire, andare in sala docenti e guardare tristemente al computer il compito in classe che avete preparato, immaginando già gli errori che dovrete correggere.
Insistere è doveroso ma, in un mestiere tanto artigianale, sperimentare è fondamentale: se un metodo non funziona, spremetevi le meningi e inventatevi qualcos’altro. Di flipped classrooms (amate e odiate) è pieno il mondo, ma anche di video, schemi, materiali di ogni tipo. Basta aprire Google. In alternativa, prendete un foglio bianco e provate a cambiare le carte in tavola, a rovesciare la prospettiva: chi l’ha detto che carta e penna hanno smesso di funzionare? Il migliore schema sul perfetto greco l’ho avuto fotocopiato dal mio professore del liceo, che lo aveva trascritto tutto a mano. Siate creativi, se ne avete il tempo: è una componente affascinante di questo lavoro.
Inoltre, potreste chiedere a un collega come fa lui a spiegare l’argomento: magari scoprite una tecnica o una prospettiva che vi fa comodo, e avrete anche creato un ambiente collaborativo, in modo da lamentarvi meno del punto 4.
5 – ‘Sono un docente precario’
Quando dovevo decidere cosa fare della mia vita, ho avuto la fortuna di avere, intorno a me, delle persone estremamente oneste e sincere. Queste persone mi hanno spiegato che insegnare è un lavoro interessante e soddisfacente sotto alcuni punti di vista, ma che arrivarci è una corsa a ostacoli infinita. Ricordo lo stupore degli studenti Erasmus, all’università, nell’apprendere il significato di sigle come SSIS, TFA, PAS, FIT, divenute tristemente note alla generazione di insegnanti cresciuta dagli anni 2000 in poi.
Diventare insegnante può voler dire imparare a osservare con attenzione la politica, e apprendere una malinconica forma di lungimiranza: come per la sanità e per le politiche sociali, la scuola è una di quelle realtà per cui la coperta è sempre troppo corta. Esserne consapevoli è una di quelle certezze che salva dalla follia e che mette fine alle liti partigiane tra sottocategorie di docenti (roba che nemmeno tra guelfi e i ghibellini): è inutile dare adito alla lotta fra docenti di pubblica e paritaria, tieffini e passini, docenti neolaureati, maddisti, da graduatoria di terza fascia e da graduatoria Granarolo. La verità è che non c’è volontà politica di risolvere la questione del reclutamento dei docenti in maniera stabile; la volontà politica non c’è, molto banalmente, perché non ci sono i fondi, qualsiasi ministro sieda sugli scranni del MIUR. E anche se, per una inaspettata congiuntura astrale, si verificassero le condizioni ideali per iniziare a distribuire abilitazioni e posti in ruolo a destra e manca, lo stipendio di un docente rimarrebbe uno tra i più bassi d’Europa.
Cosa fare, dunque? Fare tesoro di questa consapevolezza, smetterla di considerare la propria sottocategoria come l’unica ad avere diritto di precedenza; se poi si riuscisse anche a sviluppare una coscienza collettiva dei propri diritti, mettendo da parte la paura irrazionale di essere esaminati, si farebbero sicuramente grandi passi avanti.